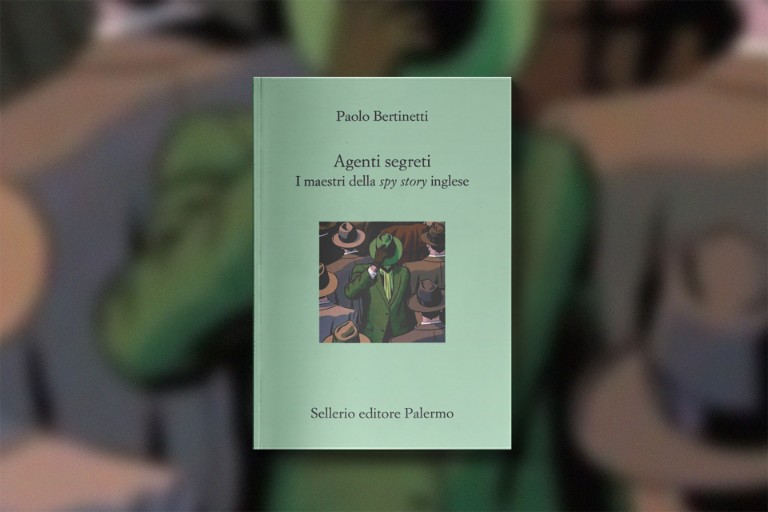Il ritorno del Grande Gioco
Lo spionaggio è al centro della scena globale.
Il Grande Gioco è tornato? È probabile che, con discrezione, non ci abbia mai lasciato, ma l’attenzione per lo spionaggio è, quella sì, tornata sicuramente a invadere pagine di giornali, ad attrarre scrittori, a suggerire complotti, a sedurre chi ama le spy story e chi fa il tifo per i servizi segreti di questo o quel Paese, non tanto (o non solo) ammirandone i valori ma misurandone l’abilità, la tecnologia, l’astuzia, il cinismo e la spietatezza.
Del resto, il materiale sul quale alimentare interesse, curiosità, passioni e apprensioni, è molto ricco. Qualche esempio. Nell’aprile del 2024 sono state arrestate a Bayreuth, in Baviera, due presunte spie che, in contatto con i servizi segreti russi, avrebbero fotografato basi Usa in Germania, venduto informazioni sensibili a Mosca, pianificato azioni di sabotaggio contro infrastrutture militari e fabbriche, allo scopo di “minare il sostegno tedesco all’Ucraina”. Uno dei due agenti era già noto alle autorità tedesche come combattente, fra il 2014 e 2016, in una milizia filorussa nel Donetsk. Solo qualche mese prima, un ex marine americano è stato condannato per aver cercato di trasmettere documenti top secret a un agente cinese. Qualche mese fa sei cittadini bulgari sono stati condannati a Londra per spionaggio a favore della Gru (il servizio di informazioni militari dell’esercito russo). La rete bulgara aveva sorvegliato giornalisti, diplomatici e truppe in Germania, Spagna, Austria e Montenegro. Nel 2024, sempre nel Regno Unito, sono stati espulsi tre diplomatici cinesi sospettati di lavorare come spie sotto copertura. E nel settembre 2024, in Libano, sono esplosi nello stesso momento migliaia di pager-buzzer (cerca-persone) usati da Hezbollah. I sospetti per l’azione da remoto, che ha richiesto infiltrazioni e società schermo, sono andati subito al Mossad israeliano, che ha negato ogni coinvolgimento. Così come sarebbe stato necessario a Israele un lungo lavoro di intelligence per compiere l'attacco contro gli scienziati iraniani che lavoravano ai progetti della repubblica islamica sull'energia atomica. Tutti casi che sembrano usciti da spy story, e che sono cronaca recente.
Questi e molti altri episodi hanno scosso l’opinione pubblica e riacceso l’interesse per il mondo dello spionaggio, un interesse che si riflette anche nella cultura popolare: in Italia stanno vivendo un vero boom i libri sul tema: da Agenti segreti di Paolo Bertinetti (Sellerio) alla riedizione di Mossad di Michael Bar-Zohar e Nissim Mishal (Feltrinelli), da Gli uomini di Himmler, Il passato nazista dei servizi segreti tedeschi, di Gianluigi Falanga (Carocci editore) a Le Spie di Stalin di Giorgio Ferrari (Neri Pozza). Fino alla nuova edizione di Servizi segreti a oriente di Costantinopoli di Peter Hopkirk (Medhelan), autore anche de Il Grande Gioco (Adelphi). E il successo delle serie tv non è certo da meno.
Fra i libri, però, si può forse cominciare da uno non propriamente dedicato alle spie, bensì a una figura psicologica e sociale che raccoglie anche questa categoria di soggetti: ne Impostori (Raffaello Cortina Editore) la sociologa della cultura e delle emozioni Gabriella Turnaturi indaga sull’”incantamento” esercitato oggi da “ingannatori che assumono con successo false identità”. Oggi, cioè nell’era del metaverso, della post verità, della facile verifica attraverso le tecnologie e dell’irrefrenabile diffusione delle fake news. La spia è un esempio perfetto di mestiere che richiede l’adesione a un altro da Sé con un coinvolgimento talmente alto da far risultare spesso rischiosa e impossibile l’uscita dall’autoinganno, l’esfiltrazione dalla propria rappresentazione. L’agente segreto, sottolinea Turnaturi, come ogni impostore diviene credibile quando e perché appare uno di noi: presentarsi come un uomo comune lo rende più vero e gli rende più facile conquistare la fiducia e il consenso di chi lo circonda. Se immaginiamo l’impostura come una rappresentazione teatrale, comprendiamo che il sostegno del pubblico è necessario a chi recita ed è indispensabile per creare una cooperazione attiva fra chi inganna e chi è ingannato. Una chiave di lettura che spiega il rinnovato fascino esercitato dalla figura della spia proprio nell’era del fake, che può tradursi benissimo nell’inganno: agli altri, a se stessi, al pubblico, alla società.
E proprio questo fascino attraversa le serie tv più stimolanti sul tema. Apripista un po’ controcorrente è stata Slow Horses, prodotta da Stati Uniti e Gran Bretagna, che ha visto il trionfo di Jackson Lamb (l’attore Gary Oldman), a capo di una squadra di agenti dell’intelligence britannica che, a causa di errori commessi, vengono retrocessi a “riserve” dell’MI5, il servizio inglese di sicurezza e controspionaggio interni. Fra le produzioni più recenti spicca poi la miseria inglese Una spia fra noi, tratto dal libro di Ben Macintyre, che racconta il disvelamento di uno dei tradimenti più famosi nello spionaggio internazionale, quello di Kim Philby. Un disvelamento che per il migliore amico e collega di Philby, Nicholas Elliot, diventa la fine di una recita teatrale costruita e vissuta insieme per decenni. Una fine alla quale non ha voluto per lungo tempo credere e, quando diventa manifesta, lo porta a riflessioni e decisioni che coinvolgono l’intero sistema dello spionaggio britannico.
Chi è stato Kim Philby? Lo racconta il giornalista e scrittore Ferrari ne Le spie di Stalin. Non si tratta certo di una storia inedita ma Ferrari, oltre a svelare nuovi particolari, ricostruisce con le vicende l’evoluzione del mondo in cui sono inserite e che le hanno determinate, le trasformazioni dell’economia, della politica e della geopolitica, della cultura, dell’arte e delle sensibilità popolari. Sono le vicende dei “Cinque di Cambridge”: Kim Philby appunto, Donald Maclean, Guy Burgess, Anthony Blunt, John Cairncross, ovvero il quintetto di spie più famoso del mondo, un gruppo di giovani brillanti, appartenenti all’élite britannica, reclutati negli anni Trenta dai servizi segreti sovietici e protagonisti di un clamoroso doppio gioco proseguito anche negli anni della Guerra Fredda. Giovani idealisti e animati da una fede nel comunismo, o meglio, dall’illusione di un’alternativa al fascismo e al capitalismo rappresentata dall’Unione sovietica di Stalin, che hanno “scalato” a Londra, fino ai vertici, i servizi segreti e la diplomazia e, contemporaneamente, si sono messi al servizio dell’intelligence di Mosca. Vite ai massimi, astute, spericolate, molto alcoliche, intrecciate a narcisismo, noia, euforia del doppio gioco.
Sì, perché Philby, Burgess, Maclean, Blunt e Cairncross hanno tradito il loro paese non soltanto per ideologia. Alcuni di loro soprattutto perché disillusi dalla classe dirigente britannica, altri, Philby in particolare, anche perché incapaci di resistere al fascino di una vita doppia, inebriante. Resta il fatto che, conclude Ferrari, ripercorrere la loro storia non fa che riprodurre alcune domande di fondo: com’è accaduto che un gruppo di rampolli della buona borghesia britannica abbia consapevolmente tradito il proprio Paese, la Corona, le proprie origini a favore di un mondo, quello sovietico, che non avevano mai conosciuto, nemmeno intravisto, solo orecchiato? Come è stato possibile che siano stati attirati e reclutati fino a diventare per quasi un trentennio spie al servizio di Mosca, senza (per quanto dato sapere) un ripensamento o un rammarico? Kim Philby ha ispirato scrittori che sono stati anche spie. Come Graham Greene, che lo ha conosciuto personalmente e ha scritto l’introduzione alla sua autobiografia, La mia guerra segreta (Mondadori), e John le Carré, che ha individuato in Philby una sorta di parricidio consumato attraverso il tradimento.
E qui si torna al Grande Gioco. Perché il rinnovato interesse per le spie sembra rispondere a un clima internazionale che ricorda appunto le logiche del Grande Gioco, il conflitto a bassa intensità tra l’Impero britannico e quello zarista, che nel XIX secolo si contesero il controllo dell’Asia centrale. Il termine Grande Gioco (in inglese The Great Game) è stato reso popolare da Rudyard Kipling in Kim (da qui il nome di Philby, che si chiamava in realtà Harold Adrian Russel), pubblicato nel 1901. Tuttavia, la sua “invenzione” è attribuita ad Arthur Conolly, capitano britannico al servizio della British East India Company e agente segreto, catturato e ucciso dall’Emiro Nasrullah Khan nel giugno del 1842 a Bukhara. Uno dei protagonisti indiretti del Grande Gioco è stato St John Philby, esploratore, ornitologo, diplomatico, agente segreto inglese convertitosi all’Islam e funzionario dell’impero britannico, a lungo ascoltato suggeritore e mediatore del re saudita Abdulaziz Ibn Saud. E padre ingombrante di Kim Philby.
Proprio “quel” Grande Gioco sembra ora destinato a riprendere forza. Lo sottolinea Ferrari, che fa riferimento al ritorno in auge della Smersh, come viene chiamata in alcuni libri di James Bond, cioè del dipartimento di controspionaggio dell’Armata rossa costituito nel 1943 la cui sigla è acronimo “Morte delle spie”. Nel 2023 ha ripreso a funzionare, con il primo ingaggio in Ucraina. Così come, da qualche tempo, i servizi segreti britannici hanno ripreso a reclutare agenti operativi russofoni. Mentre, fino a qualche anno fa, i più richiesti erano quelli di lingua araba. Sì: il Grande Gioco è tornato.
Categoria: Cultura
Titolo: Il ritorno del Grande Gioco
Autore: Sergio Bocconi, giornalista